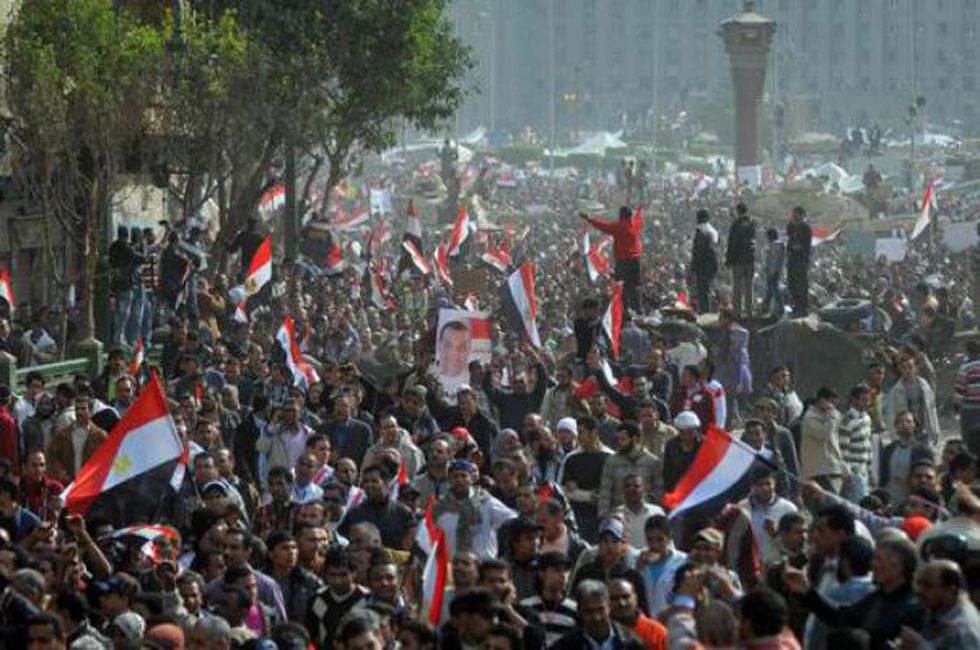«Tra il dire e il fare
c’è di mezzo il mare». Così recita un vecchio proverbio popolare. Per
descrivere la crescente tensione tra Stati Uniti e Iran in questi ultimi giorni
che conducono verso la fine del 2011 non sembra esistere espressione migliore. E
ciò non solo perché il motivo del contendere ruota attorno alla libera
navigazione nelle acque dello Stretto di Hormuz, ma anche e soprattutto perché tra
l’escalation verbale e quella diplomatico-militare sembra davvero passare molta
acqua sotto i ponti. L’apprensione è (e, forse, deve rimanere) grande. Ma, se
cerchiamo di interpretare con realismo gli interessi nazionali di America e
Iran, il pericolo di un nuovo conflitto non dovrebbe essere dietro l’angolo. Alla
minaccia di ieri del vicepresidente iraniano Mohamed Reza Rahimi di bloccare
con facilità e rapidità il passaggio delle imbarcazioni in uscita e in entrata
dal Golfo Persico come contropartita a possibili nuove sanzioni contro il
programma nucleare iraniano, è giunta oggi la tempestiva risposta di Rebecca
Rebarich, portavoce della V flotta americana di stanza in Bahrain, la quale ha
affermato con risolutezza che «ogni interruzione del traffico navale nello
stretto di Hormuz non sarà tollerata».
Angusto
braccio di mare che divide la Penisola arabica dalle coste iraniane, lo stretto
è un crocevia fondamentale per il traffico mondiale del greggio trasportato via
mare. Pertanto, un suo eventuale blocco per mano dalla Marina militare
iraniana, che in questi giorni sta effettuando delle esercitazioni proprio in
quelle acque, potrebbe rappresentare non solo un serio problema per il
commercio energetico mondiale, ma anche determinare tanto prevedibili quanto
non quantificabili aumenti del prezzo del greggio (regolato nella sua
quotazione attraverso strumenti finanziari assai sensibili agli equilibri
politici mondiali). Due conseguenze che non possono essere tollerate né
dall’Occidente, né dalle Grandi potenze asiatiche.

Il
nodo strategico e geopolitico rappresentato dalla disputa iraniano-statunitense
sullo stretto di Hormuz è assai complesso e intricato. Per tentare di scioglierlo,
occorre tenere ben presenti i tanti fattori in gioco sia nell’instabile e
proteiforme equilibrio della regione mediorientale, sia nei sistemi politici
interni di entrambi i Paesi. E una tale operazione conduce inevitabilmente ad
allontanare l’ipotesi di imminenti scenari di guerra. Da un lato, infatti, non sembra
essere nell’interesse iraniano destabilizzare lo status quo di un Medio Oriente in cui – anche grazie alla
disastrosa campagna militare in Iraq degli Stati Uniti – il Paese di Mahmud
Ahmadinejad e Ali Khamenei gode di una posizione strategica rilevante, che
potrebbe solo deteriorarsi in seguito a uno scontro armato e passare nelle mani
di una sempre più intraprendente Turchia. Al tempo stesso, anche gli Stati
Uniti – ancora impegnati in Afghanistan e sempre più attenti a ciò accade nella
regione dell’Asia-Pacifico – non sembrano ben disposti a imbarcarsi in una
nuova avventura bellica. Un’impresa, quest’ultima, troppo dispendiosa in
termini politici, economici e umani. Dall’altro lato, se rivolgiamo lo sguardo
verso l’interno, possiamo notare come l’Iran sia alle prese con una situazione
di forte crisi economica (aggravata dalle attuali sanzioni internazionali). Una
situazione che gli scenari di guerra – ma, conta dirlo, anche quelli di nuove e
più aspre sanzioni – renderebbero ancora più drammatica non solo da sostenere
per la popolazione, ma anche da gestire per il potere in termini di controllo
politico. In egual modo, in America, la corsa alle elezioni presidenziali del
2012 sconsiglia a Obama di arrivare al punto di rottura definitivo.


Molto
probabilmente, la crisi – in questo momento, ancora più virtuale che reale –
dello stretto di Hormuz si risolverà in un blocco parziale del passaggio di
navi, con lo scopo dichiarato da parte dell’Iran di far aumentare il prezzo del
greggio. Un possibile aumento del prezzo del petrolio che gli Stati Uniti e con
loro tutta la comunità internazionale cercherà di oltrepassare e di far
ricadere sul Paese degli Ayatollah. La soglia di tolleranza di Iran e Stati
Uniti varierà in relazione all’evolversi degli eventi, che sono e (devono
rimanere) imprevedibili. Ma, ora, è possibile affermare che la saggezza
popolare mostra ancora tutta la sua perspicace validità e il suo più crudo
realismo. «Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare», anche a Hormuz.
Questo articolo è apparso il 30 dicembre 2011 su www.ilsussidiario.net